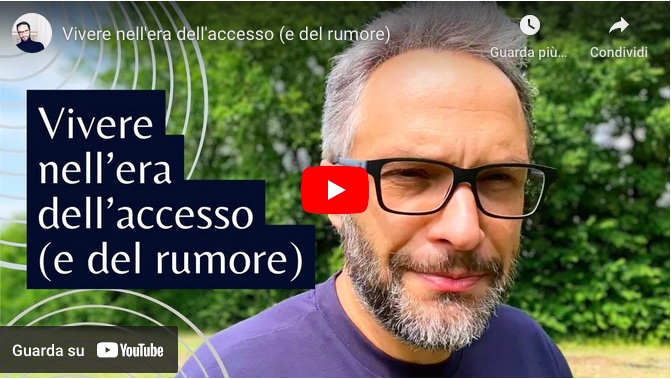L’Ofcom (l’autorità di controllo per le società di comunicazione del Regno Unito), in un’indagine condotta nel 2016 riportava un dato sconcertante: le persone adulte oggi trascorrono più tempo connessi alla rete che dormendo. La mole di email, notifiche e messaggi a cui siamo sottoposti quotidianamente è impressionante, e spesso ne diventiamo schiavi, risultando incapaci di rimanere scollegati per più di un’ora.
E’ la cultura patologica dell’AlwaysOn, l’irrefrenabile impulso all’essere sempre attivi e connessi con una costante disposizione alla comunicazione e al multitasking.
Tale fenomeno è una naturale conseguenza della digitalizzazione dei rapporti, che progressivamente ha spostato la percezione del senso di appartenenza sociale (tra i bisogni fondamentali dell’essere umano) nello spazio virtuale del web ed in generale nello sviluppo di interazioni mediate dalle interfacce digitali. Inoltre, la possibilità di stabilire interazioni su più canali contemporaneamente, rende il lavoro nell’era del web molto esigente a livello di risorse psicologiche. In questa prospettiva, come si evolvono i modelli di organizzazione del lavoro?
Tra le tendenze più in voga, il cosiddetto Smart Working oggi sembra essere indubbiamente la soluzione di organizzazione del lavoro che meglio sfrutta le nuove tecnologie. Infatti, non passa giorno senza che editorialisti, consulenti ed esperti vari esaltino l’ennesima azienda smart gloriosamente convertita al lavoro agile, osannato come l’indiscutibile nuova frontiera della libertà individuale del lavoratore.
Ma quali possono essere i rischi e le problematiche dal punto di vista psico-sociale di questa modalità di lavoro-connessa?
Ad un primo sguardo, lo Smart Working sembrerebbe realmente rappresentare una buona opportunità per tutte quelle persone che desiderano – o che necessitano – di gestire con maggiore autonomia il loro tempo. Tuttavia, soprattutto nelle realtà industriali anglofone, ove l’applicazione di questo modello viene spesso interpretata in modo troppo “spensierato” ed integrale, possono emergere preoccupanti criticità.
Lo dimostrano i dati raccolti dal gruppo di ricerca SOCRG (Switched On Culture Research Group), composto da diversi psicologi ed esperti di varie università europee per analizzare e fronteggiare i rischi della cultura del sempre accesso. Rendere evanescenti o addirittura abbattere i confini tra lo spazio-tempo dedicato al lavoro e lo spazio-tempo dedicato alla vita privata, di fatto annulla le possibilità di vero bilanciamento tra le due dimensioni (work-life balance) con il rischio di assistere sempre più spesso a fenomeni di “presenteeism”, ovvero d’incapacità di assentarsi dal lavoro, anche in casi di grave malattia, legata al timore stressante di ricevere comunicazioni importanti mentre non si è connessi o alla percezione di rimanere esclusi dalle dinamiche del gruppo di lavoro in cui si è inseriti.
Alla luce di questi dati, appare evidente come l’applicazione del modello di “lavoro agile”, oltre ai presunti benefici in termini di costi per l’azienda, comporti in ogni caso una conseguente responsabilità a carico del datore di lavoro di predisporre degli adeguati sistemi tecnologici e organizzativi in grado di assicurare il corretto adempimento del diritto di disconnessione da parte del lavoratore.